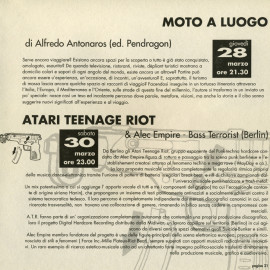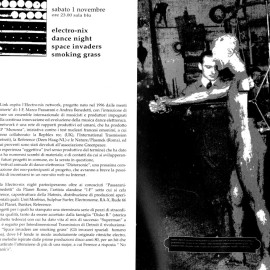E poi, molto importante per la tessitura esistenziale del luogo, la creazione di spazi di servzio, sempre negli interrati: libreria, caffè, internet-point, il mitico ristorante di Nonna Piri, la mensa, finalmente. Quest’area rese il Link uno spazio di estremo agio rispetto ad altri posti autogestiti in Italia: c’era la vera macchina del caffè da bar, c’era il riscaldamento, c’erano delle sedute comode e c’era la luce per leggere (la corrente la rubacchiavamo un po’).

Abbiamo portato tutto noi, il poco che avevamo (molto materiale per il cinema, primariamente, 16 e 35mm, video-proiettori, monitor..) o lo abbiamo comprato strada facendo, per cui si facevano delle campagne di finanziamento per l’acquisto di attrezzature, con molta fatica ma ci si riusciva.
Come facevate ad avere un buon sound-system?
D.G.: Partiti decisamente malino, ci pagavamo poco, e investivamo. C’era uno spirito che ti permetteva di dire “no gli incassi non me li mangio tutti!”. Erano sacrifici; il primo impianto serio fu un Turbosound da 40 milioni circa, ma ci son voluti tre anni, credo. Non so, a distanza di tempo se fosse veramente un buon impianto. Le tecnologie si sono parecchio evolute nel frattempo. Poi c’era tutta la cultura dei sound-system, che portava in giro o depositava lì impianti che non appartenevano a noi, ma alle “tribe” che li suonavano.
Come decidevate la programmazione?
D.G.: Come dicevo, la programmazione era organizzata come in una casa editrice: c’erano delle redazioni e un coordinamento editoriale, con una riunione periodica plenaria. L’assemblea vera e propria, era invece il momento dove si discutevano le questioni generali e si mediavano le eventuali problematiche, i conflitti e le tensioni, tra tutte le componenti, anche quelle non “redazionali” dello spazio. A livello di scelte tendevamo a fare tutto quello che le università italiane e le istituzioni non facevano: teatro non convenzionale, cinema sperimentale, videoarte, azionismo e performance, musica di ricerca, vecchie avanguardie e nuove correnti underground. Le cose che ci interessavano insomma e che se non le portavamo noi in Italia non si vedevano se non con estrema fatica.
Tutte le sottoculture musicali, miriadi di correnti, con l’elettronica hanno provato a rimediarsi, letteralmente, a rifondarsi su di un nuovo media. Detroit per la techno, Londra per la jungle, il drum’n’bass e il dub, sono state solo l’apice di quel fenomeno…
Tendevamo ad una massima apertura possibile verso tutti i fenomeni dei quali venivamo a conoscenza. E fra questi succede che proprio a metà degli anni 90 c’è lo scoppio della rivoluzione elettronica. Noi ci siamo trovati in mezzo. Cosa stava succedendo? Tutte le sottoculture musicali, miriadi di correnti, con l’elettronica hanno provato a rimediarsi, letteralmente, a rifondarsi su di un nuovo media. Detroit per la techno, Londra per la jungle, il drum’n’bass e il dub sono state solo l’apice di quel fenomeno…. È arrivato tutto sincronicamente. La cultura industriale è confluita e ha fondato nuove estetiche: Pan Sonic ed Atari Teenage Riot, le metropoli meticce hanno mescolato le carte, le geografie, i ritmi e gli stili. Si sviluppano la techno minimale della Mille Plateaux e della mitteleuropa e si creano i nuovi paesaggi urbano-tropicali della Mo-Wax. Rinasce l’Afro-futurismo con personaggi come dj Spooky….È successo veramente di tutto, un paio di anni vertiginosi e non era merito di nessuno, tutto era nell’aria e tra di noi c’era Giorgio Manservigi che riusciva a parlarne con senno. Poi viene fuori anche il vintage, con un recupero di parte della tradizione leggera italiana, un anticipo della retromania, figlia della cut’n’mix culture di quegli anni. Suonano anche i Montefiori Cocktail, e Notte Vidal diventa lo snodo di questo strano divertimento, tutti i giovedì sera, in un momento che serviva per scaldare i motori della settimana tipo, con un clima frizzante ma rilassato.
Eravamo contemporaneisti ma con anche dei riferimenti storici, c’era una sorta di asincronia in tutta quella macchina che in 5 anni ha maturato una consapevolezza e un’accuratezza nel funzionare che ha espresso dei picchi molto belli. C’erano delle serate che erano pazzesche. Quando erano aperti tutti gli spazi in ognuno potevi trovare una cosa, un fenomeno, attraversando un palinsesto di successioni inaspettabili. Mescolamenti strani di cose che tra loro non c’entravano, ma che lì dentro funzionavano. Forse il momento di massima improbabilità sono state le Incursioni organizzate con Luca Vitone e che hanno portato poi a due edizioni di Hops!, quando si è aggregato anche Andrea Lissoni. Quello che succedeva era una sorta di reinterpretazione della vita del luogo, della sua natura sociale, da parte di artisti che intervenivano modificando, in modo molto sperimentale, la funzione degli spazi con cose veramente bizzarre. Momenti assurdi, anche dal punto di vista produttivo. Follie e fallimenti, certo, che vanno a braccetto. Ci fu una prova generale di drammatizzazione dello spazio e dei suoi componenti, da parte di Giorgio Barberio Corsetti: fece il tentativo di investire tutto il Link e anche tutte le persone che vi lavoravano per la costruzione di uno spettacolo totale a partire dalla narrazione di un antico rituale induista: impresa impossibile. Cattelan il più alacre tra i pigri, se la voleva cavare mandandoci tutti a riposo per un weekend. E poi certo, ci sono state anche serate particolarmente sfortunate eh, c’erano giornate nere e serate nere.
Bologna e l’Italia come hanno risposto a questo tipo di proposta?
D.G.: All’inizio la nostra attività non era percepibile, è stata anche un filo impopolare. Poi è iniziata piano piano ad arrivare gente di ogni luogo e tipo, la più disparata. Ritorna qui la sindrome dell’assedio. A un certo punto non si capiva chi era l’assediante e chi l’assediato. L’immagine che ho avuto in mente, ad un certo punto, era quella di un grande accampamento di barabri, posto alle porte di una città. Tutti erano bene accolti, venissero da lontano o dall’interno delle mura: nessuno gli chiedeva le generalità.
A cosa v’ispiravate? Quali erano i vostri riferimenti?
D.G.: Ognuno aveva il suo, sicuramente ci ispiravano molte cose che succedevano nel nord Europa…
Come lavoravate alla rivista?
D.G.: In primis ci dovevano essere gli eventi, gli accadimenti e, chi li proponeva, i componenti delle redazioni, produceva i materiali utili per la comunicazione e per la realizzazione della rivista, passandoli al laboratorio di grafica, la Loew, un team eccellente, a un certo punto. Era un magazine dove si spiegavano e raccontavano delle cose, con alcuni approfondimenti teorici, identificavamo dei reprints o pubblicavamo testi inediti che affrontavano aspetti di retroscena che potevano servire al lettore per andare più dentro ai fenomeni; cercavamo anche noi di capirli. La presentazione degli artisti era divulgativa, gli approfondimenti erano più scientifici, senza fare dell’accademismo dal quale ci eravamo allontanati parecchio.
Raccontaci come si è evoluto il Link?
D.G.: Direi che si è trattato di un processo di saturazione. A un certo punto gli spazi erano saturi, pieni da tutti i punti di vista. Si è raggiunto un punto di evoluzione dove si è stati in grado di poter fare alcune scelte, che è stato il punto di equilibrio. Il punto di saturazione, è stato raggiunto, la uso come una sorta di metafora, con la bonifica dell’ultimo spazio insalubre. Era un buco nero da dove usciva anche l’acqua, quando cadevano piogge copiose, perché era al di sotto di una falda acquifera. Lì investimmo una cifra per noi significativa facendolo ristrutturare da Flavio Favelli che pavimentò la sala con delle lastre di vetro bianco riciclate; poi montammo un sistema audio dolby-surround con un buon video-proiettore a tre tubi. era la Schwarz Raum, un’idea di Lucio Apolito; lì facevamo delle proiezioni nootropiche (CNN), nelle nottate più mefitiche, curate un po’ dall’Opificio Ciclope e un po’ dalla redazione Cinema e video. È stata la celebrazione dell’arte come spreco, forse: investire simbolicamente il surplus in un buco nero..
È un punto che coincide anche con la saturazione dell’immaginario a livello mondiale, siamo nel 1999, credo: da un lato i fenomeni di musica elettronica si normalizzano e non hanno più quell’impatto rivelatorio, dall’altro lato esce una nuova onda visiva corrispondente con la digitalizzazione dell’immagine (da lì nascerà poi Netmage); infine il web: esplode la grande bolla del 2000 che falcidia una generazione. Qui dovremmo parlare degli anni zero. Ma nella mia esperienza ho la sensazione che i cosiddetti decenni, quello del 90 e quello del 2000 non coincidano, come sapore fenomenico, ma si sfasino tra un 1995 e un 2005.
siamo nel 1999, credo: da un lato i fenomeni di musica elettronica si normalizzano e non hanno più quell’impatto rivelatorio, dall’altro lato esce una nuova onda visiva corrispondente con la digitalizzazione dell’immagine (da lì nascerà poi Netmage); infine il web: esplode la grande bolla
In quel “decennio” sfasato si è consumata la trasformazione, o faremmo meglio a chiamarla trasmigrazione. Eravamo partiti come una certa unione di piccoli soviet (passatemi il termine, in senso letterale, in russo significa “consiglio”) che ha gentilmente occupato una “fabbrica” vuota, avviando uno strano esperimento di organizzazione della produzione. Avevamo bisogno di stare insieme per procurarci dei mezzi di produzione che all’epoca erano carissimi se non proibitivi. Ora i mezzi sono alla portata di tutti, siamo nell’era delle App. Ormai ognuno ha la sua unità di lavoro a casa – o addirittura in tasca – e non c’è più l’esigenza di stare insieme per produrre. Parallelamente, sempre nello stesso arco di tempo, si è creata una sorta di istituzionalizzazione dei processi culturali; è un fenomeno più ampio e profondo di quanto possa apparire a prima vista. In Italia nascono i vari Macro, Maxxi, Madre… quello che noi facevamo negli anni 90 non lo faceva nessuna istituzione italiana, ma alla svolta degli anni Zero, piano piano, incominciano a nascere questi spazi, si espande la figura del curatore, proliferano le residenze e le borse di studio e gli artisti stessi passano molta parte del loro tempo a compilare applications. Questa sistematizzazione, non dico che sia stata un effetto derivato dal nostro lavoro, penso però che sicuramente il Link in Italia abbia avuto un ruolo formativo per tutta una generazione, perché l’ha esposta a determinati tipi di fenomeni estetici. Una domanda si è iniziata a creare a partire da determinati stimoli. Il processo di istituzionalizzazione si sviluppa anche per cercare di dare delle risposte a questa domanda, o per cercare di cogliere questa opportunità.
In Italia nascono i vari Macro, Maxxi, Madre… quello che noi facevamo negli anni 90 non lo faceva nessuna istituzione italiana, ma alla svolta degli anni Zero, piano piano, incominciano a nascere questi spazi, si espande la figura del curatore, proliferano le residenze e le borse di studio e gli artisti stessi passano molta parte del loro tempo a compilare applications.
Come vi rapportavate con le istituzioni e con la burocrazia?
D.G.: Tra gli amministratori e i politici vi erano posizioni diverse, credo. Non c’era una contrapposizione tra blocchi, c’erano piuttosto delle persone, alcune con un certo retaggio, che potevano guardare alla nostra esperienza con curiosità; altri che hanno tollerato – presumo – qualcosa che, pur non essendo uno spazio occupato, non aveva, giocoforza direi, i crismi di una istituzione per bene. Burocrazia, il meno possibile. Sarebbe potuto crearsi un percorso possibile di istituzionalizzazione. Aveva iniziato a provarci Roberto Grandi, docente di comunicazione di massa e allora Assessore alla Cultura: era uno di quegli intellettuali curiosi, ma il processo era lungo, ed è stato di fatto interrotto da un cambio di giunta, il “crollo del muro di Bologna”, come lo ha chiamato qualcuno. Sarebbe servito un grande sforzo, da parte di tutti. Non è che la giunta successiva, di “destra”, si sia poi rivelata ostile. Del resto i loro figli erano in parte cresciuti anche lì dentro e mi immagino qualche buffa discussione familiare. Ma lo slancio sarebbe dovuto essere molto serio, anche dal punto di vista finanziario. E invece il piano era quello di abbattere quell’edificio e trasferire tutto in un’altra area, in mezzo al nulla.
Come si rapportavano gli altri centri sociali e le altre realtà?
D.G.: All’inizio ci guardavano male, avevamo infranto due tabù: il primo sul trattare con le istituzioni, l’altro sul provare ad introdurre delle forme di auto-reddito. Non abbiamo mai contestato le loro ragioni, abbiamo provato a sperimentare un altro percorso. Poi è successo qualcosa; nascono nuove occupazioni, come a dimostrazione che una strada nuova non preclude il percorso delle precedenti. Nasce il TPO, e anche con il Livello 57 è iniziato un coordinamento su alcuni temi. Primo Moroni aveva capito cosa stavamo facendo, aveva iniziato ad introdurre alcuni elementi nel dibattito nazionale. Era un intellettuale stimato in ambienti molto diversi. Purtroppo anche lui è venuto a mancare prematuramente.
E.Z.T.: A che stadio pensi siano tutte le sottoculture che hanno portato alla nascita del Link Project?
D.G.: Non saprei dirti, il tentativo di rimediazione di tutta una serie di certe sottoculture come sia finita. Quella è un’analisi tutta da affrontare, nel senso che per esempio io oggi come oggi, penso che quella scena elettronica sia morta.